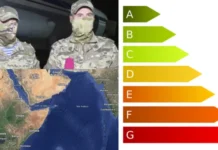Gli eccessi degli ultras sono oggetto della riprovazione di tutti gli altri appassionati di sport. Oggigiorno come nel passato. Il fenomeno della tifoseria violenta risulta oggetto di condanna in molti testi latini, in relazione ai disordini che si verificavano durante e dopo le corse di carri nel Circo, a Roma come nelle più periferiche province. La passione dei Romani per le gare equestri risale al tempo della monarchia e della neonata repubblica. Le scuderie (factiones) erano inizialmente solo due: i rossi (factio russata) ed i bianchi (factio albana), legate rispettivamente all’estate ed all’inverno, essendo i giochi del Circo indissolubilmente legati alle feste religiose. Il carattere sacro delle corse era tale che al pubblico era vietato consumare cibi e bevande mentre assistevano alle gare. Lo stesso Ottaviano Augusto, mentre presenziava allo spettacolo nel Circo Massimo, ebbe a rimproverare uno spettatore del settore riservato ai “cavalieri” perché lo vide mangiare e bere durante una pausa tra una corsa e l’altra.
Gli eccessi degli ultras sono oggetto della riprovazione di tutti gli altri appassionati di sport. Oggigiorno come nel passato. Il fenomeno della tifoseria violenta risulta oggetto di condanna in molti testi latini, in relazione ai disordini che si verificavano durante e dopo le corse di carri nel Circo, a Roma come nelle più periferiche province. La passione dei Romani per le gare equestri risale al tempo della monarchia e della neonata repubblica. Le scuderie (factiones) erano inizialmente solo due: i rossi (factio russata) ed i bianchi (factio albana), legate rispettivamente all’estate ed all’inverno, essendo i giochi del Circo indissolubilmente legati alle feste religiose. Il carattere sacro delle corse era tale che al pubblico era vietato consumare cibi e bevande mentre assistevano alle gare. Lo stesso Ottaviano Augusto, mentre presenziava allo spettacolo nel Circo Massimo, ebbe a rimproverare uno spettatore del settore riservato ai “cavalieri” perché lo vide mangiare e bere durante una pausa tra una corsa e l’altra.
L’equites gli rispose: “Cesare, se ti allontani dal tuo posto, tu lo ritrovi libero!”. E siamo all’epoca in cui il Circo conteneva già 150 mila spettatori. Durante il periodo repubblicano, si erano formate altre due factiones: gli azzurri (factio veneta) ed i verdi (factio prasina), anch’essi collegati alla stagione autunnale e primaverile. Queste scuderie divennero le più amate dai Romani, le più ricche e con i cavalli e gli aurighi migliori, tanto che nel tardo impero i bianchi confluirono con i verdi della Prasina ed i rossi vennero assorbiti dagli azzurri della Veneta. Nel Circo di Costantinopoli, ancora per alcuni secoli, le scuderie dei Verdi e degli Azzurri si contesero il favore del pubblico e divennero quasi due movimenti politici in lotta tra di loro, persino su argomenti teologici. L’Imperatore Domiziano, nel primo secolo dopo Cristo, introdusse due nuove fazioni con i colori di Roma, porpora ed oro, ma non attecchirono nel cuore degli appassionati e cessarono di esistere alla morte di Domiziano.
Per gli antichi Romani, andare ad assistere alle gare era una vera fatica: per trovare posto si recavano al Circo Massimo prima dell’alba e vi rimanevano fino al tramonto, sotto il sole estivo oppure al vento di tramontana. E non c’era il “velario” come al Colosseo a garantire un po’ d’ombra. La giornata iniziava con l’ingresso della Pompa circenses, la processione che, proveniente dal colle Capitolino, trasportava le immagini e le statue degli Dei a cui erano dedicati i giochi, per collocarle nel Pulvinar, il palco dal quale gli Dei (e l’Imperatore) assistevano alle corse, costruito a ridosso del Palatino, all’altezza del traguardo.
Nel frattempo, nelle 12 stalle sul retro dei carceres, la costruzione che occupava il lato rettilineo verso il Tevere, si predisponevano i carri per la prima gara, procedendo all’estrazione a sorte dei posti di partenza. All’uscita dai cancelli dei carceres, i concorrenti si allineavano su una linea arcuata che doveva compensare il vantaggio di quelli più prossimi alla spina, il corpo centrale che divideva in due l’arena e che era stato costruito leggermente obliquo, per rendere più difficoltosa la curva attorno alla meta.
Il magistrato che aveva organizzato – e pagato – i giochi circensi di quel giorno, dava il segnale di partenza dall’alto dei carceres, lasciando cadere la mappa, un pezzo di tela bianca. Solo nel tardo Impero, la partenza fu data anche con uno squillo di trombe, per evitare che gli aurighi dovessero girarsi per vedere la caduta della mappa. Alla partenza, i carri si contendono la parte sinistra della pista, accanto alla spina, anche se dopo 500 metri devono affrontare la curva a sinistra della Meta per ultimare – dopo altri 500 metri – lo spatium, il primo dei sette giri di pista previsti per ciascuna gara. Una corsa di sette chilometri, tirata fino allo spasimo, il clamore del pubblico, le reciproche scorrettezze degli aurighi, gli incidenti, il grande giro delle scommesse clandestine, sono queste le emozioni del Circo che ne hanno motivato il successo plurisecolare in tutto il territorio dell’impero di Roma. Una ricostruzione fedele delle corsa e dell’atmosfera del Circo, si trova nel kolossal ”Ben Hur”, un film che riscosse un grande successo di pubblico e fece man bassa di premi Oscar.
Gli aurighi indossavano una corta tunica del colore della fazione, con un corsetto a strisce di cuoio ed un caschetto. Per avere le mani libere, essi legavano le redini attorno alla vita e portavano alla vita un falcetto col quale liberarsi in caso di incidente (delle naufragio). Solitamente, gli aurighi erano schiavi o criminali pregiudicati di estrazione popolare ed il rischiare la vita nel Circo era una possibilità di riscatto sociale. Al vincitore della corsa, che in epoca repubblicana veniva premiato con una corona d’alloro o un ramo di palma, durante l’impero veniva concesso l’affrancamento dalla schiavitù oppure –se già libero cittadino- riceveva dei doni di valore od anche somme di denaro. Altre cospicue entrate derivavano all’auriga dalle percentuali sulle scommesse, tanto che i più bravi divennero ricchissimi, come il campione di nome Diocle, che vinse circa 3 mila corse di bighe e millecinquecento di quadrighe, ritirandosi della gare con 35 milioni di sesterzi. Altri campioni del Circo, il cui nome è giunto fino a noi, sono stati Scorpus (vincitore di 1042 corse), Pompeo Epafrodito (primo in 1467 gare) e Pompeo Musclosus (ben 3559 vittorie). Per altri motivi è rimasto famoso anche Ierocle, un auriga che nel 221 d.C. sposò l’imperatore Elagabalo, dopo che questi aveva divorziato da una vergine Vestale. Sono noti anche i nomi di alcune delle vittime nel Circo: Marco Aurelio Molliccio, morto a 20 anni, dopo 125 vittorie; Tusco, che fu vincitore di 56 corse, ma perse la vita e 24 anni; Crescente, deceduto a 22 anni, dopo aver accumulato 1,6 milioni di sesterzi con i suoi numerosi successi.
I cavalli utilizzati nelle corse del Circo provenivano da allevamenti di diverse parti dell’Impero: Spagna, Grecia, Nord Africa, ma anche dalla Sicilia e dall’Italia peninsulare, tutti rigorosamente dotati di un “pedigree” certificato.
Per le gare si utilizzavano animali di almeno quattro anni, bardati con finimenti di qualità e con pennacchi e collari con i colori della factio d’appartenenza, nonché con appesi amuleti contro la cattiva sorte. Il carro che dovevano trainare era in legno ed abbastanza leggero: il pianale corto, il parapetto basso e le due ruote a quattro soli raggi; l’asse era ribassato (per tenere basso il baricentro nell’affrontare le curve) ed al timone era legato uno soltanto dei cavalli, al quale venivano assicurati gli altri. Nelle gare, i carri erano trainati da un numero variabile di cavalli ed esisteva una denominazione specifica per ciascun tipo di tiro: ovviamente, la biga (a due cavalli), la triga (a tre), la quadriga (a quattro), ma anche seiuges (tiro a sei), septeiuges e octoiuges (con sette od otto animali), fino al decemiuges, per un tiro a dieci. Ma l’animale al quale si dava la maggiore importanza ed era oggetto del maggiore addestramento era il cavallo che occupava il posto di sinistra nel tiro, perché guidava gli altri cavalli in tutte le curve attorno alle mete e quindi era destinato a diventare il prediletto delle tifoserie. I cavalli che superavano le cento vittorie erano detti centenari e venivano celebrati dalla scuderie e dai tifosi con targhe di marmo ed epitaffi sulle loro sepolture. Per questo ci sono pervenute iscrizioni celebrative dei cavalli Tuscus e Victor, vincitori di 386 e 429 corse rispettivamente, veri beniamini degli appassionati, che avevano scommesso su di loro anche cifre importanti e vollero dimostrare la loro gratitudine. Anche allora c’erano persone colpite dalla “febbre da cavallo”!